Un film sulla vita di Giacomo Leopardi sembrerebbe istintivamente
impensabile. Come si
fa a raccontare un genio, un animo complesso, dolente e infinitamente
infelice, la sua epoca così singolare?
Raccontare sulla pellicola la storia del più strordinario genio della nostra Letteratura pare non fosse idea nuova. Fu ventilata questa possibilità molti anni fa, una decina credo, con Sergio Rubini nel ruolo del protagonista. Produzione che poi non fu mai realizzata. La sfida viene raccolta da Mario Martone, in una produzione che porta la sua firma nello stile e nel rigore del racconto.
Raccontare sulla pellicola la storia del più strordinario genio della nostra Letteratura pare non fosse idea nuova. Fu ventilata questa possibilità molti anni fa, una decina credo, con Sergio Rubini nel ruolo del protagonista. Produzione che poi non fu mai realizzata. La sfida viene raccolta da Mario Martone, in una produzione che porta la sua firma nello stile e nel rigore del racconto.
Questo è un film che emoziona, uno di quelli che alla fine ci lascia attoniti e incapaci di lasciare la sala del cinema, mentre quella colonna sonora dal ritmo moderno descrive l'ultimo canto di Giacomo, il testamento poetico che declama dinanzi al cielo notturno di Napoli, e lui ancora una volta come sgomento dinanzi al creato, percepito fin dalla sua cosmogonia, come se la sua mente si dilatasse un'ultima volta dinanzi a spazi siderali che egli percepisce fin dalla sua adolescenza.
Elio Germano, il suo interprete, vince pienamente la sua prova più
difficile finora affrontata. Credibile, struggente, tenero, dolente,
traspira quel dolore ineffabile che Leopardi ha sublimato in versi di
infinita e ineguagliabile bellezza, oltre che in tante opere
scientifiche e filosofiche.
Il rigore di Martone è assoluto, la storia del giovane Leopardi è un racconto che in tutta la prima parte ha come scenario la Recanati amata e odiata, gli ambienti austeri della casa, l'ordine e la dedizione alla biblioteca, centinaia e migliaia di fogli scritti minuziosamente, le solitarie passeggiate sul colle dal quale immaginare scenari nuovi, la finestra nella quale è incorniciata una giovane Teresa Fattorini destinata a morte precoce.
Su tutto il dolore di un giovanissimo Leopardi che subisce l'austerità della madre e l'ossessivo attaccamento paterno, mentre una malattia deformante affligge i suoi giorni e paradossalmente gli dona un osservatorio personale dal quale percepire il destino degli uomini.
Il rigore di Martone è assoluto, la storia del giovane Leopardi è un racconto che in tutta la prima parte ha come scenario la Recanati amata e odiata, gli ambienti austeri della casa, l'ordine e la dedizione alla biblioteca, centinaia e migliaia di fogli scritti minuziosamente, le solitarie passeggiate sul colle dal quale immaginare scenari nuovi, la finestra nella quale è incorniciata una giovane Teresa Fattorini destinata a morte precoce.

Su tutto il dolore di un giovanissimo Leopardi che subisce l'austerità della madre e l'ossessivo attaccamento paterno, mentre una malattia deformante affligge i suoi giorni e paradossalmente gli dona un osservatorio personale dal quale percepire il destino degli uomini.
...io non ho bisogno di stima, di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.
Giacomo è come assetato di qualcosa di cui percepisce l'esistenza e allo stesso tempo sente che a lui non è destinato. Il dolore si alimenta di un'insoddisfazione profonda, pertanto dilaga e segna irrimediabilmente le sue relazioni col mondo che incontrerà. Infatti, nella seconda parte, Leopardi ha acquisito la sua libertà, vive a Firenze, poi Roma, poi Napoli, quel mondo che aveva idealizzato e dinanzi al quale resta deluso, nell'amore non condiviso dall'aristocratica Targioni Tozzetti, nella constatazione di non appartenere a una società che inneggia a "magnifiche sorti e progressive" dalle quali si sente a distanza, nell'unico conforto dell'amicizia di Antonio Ranieri.
Nel mutare degli scenari non muta Giacomo, che precocemente era giunto al Vero, al Dubbio come suo assoluto, e al quale non resta che porsi come spettatore dinanzi alle miserie degli uomini, compatirli e vivere le sue altissime intuizioni mentre la storia si fa dinanzi ai suoi occhi.
Ogni delusione è pertanto linfa vitale dentro Leopardi, che si contorce
fino alla paralisi in uno spasmo che è già morte, ultimo viaggio che
Silvia additava nella chiusa della canzone a lei intitolata.
Gli ultimi giorni di Leopardi sono lenti e riflessivi, è adulto ma in lui non ha mai smesso di vivere il fanciullo recanatese che si dibatteva nel suo furore intellettuale.
Se dovessi immaginare un centro assoluto di questa mirabile pellicola, esso si concretizzerebbe nella frase che tuona dinanzi al padre Monaldo: Io odio questa prudenza che rende impossibile ogni grande lezione, padre!!! Qualcosa che rende Giacomo Leopardi non più lontano nel tempo, nella forma, nell'intelletto, ma straordinariamente vicino, attuale, in quell'anelito di vita che accomuna tutti i grandi animi che sanno percepire la Bellezza e farsene vivi assertori.
Gli ultimi giorni di Leopardi sono lenti e riflessivi, è adulto ma in lui non ha mai smesso di vivere il fanciullo recanatese che si dibatteva nel suo furore intellettuale.
Se dovessi immaginare un centro assoluto di questa mirabile pellicola, esso si concretizzerebbe nella frase che tuona dinanzi al padre Monaldo: Io odio questa prudenza che rende impossibile ogni grande lezione, padre!!! Qualcosa che rende Giacomo Leopardi non più lontano nel tempo, nella forma, nell'intelletto, ma straordinariamente vicino, attuale, in quell'anelito di vita che accomuna tutti i grandi animi che sanno percepire la Bellezza e farsene vivi assertori.
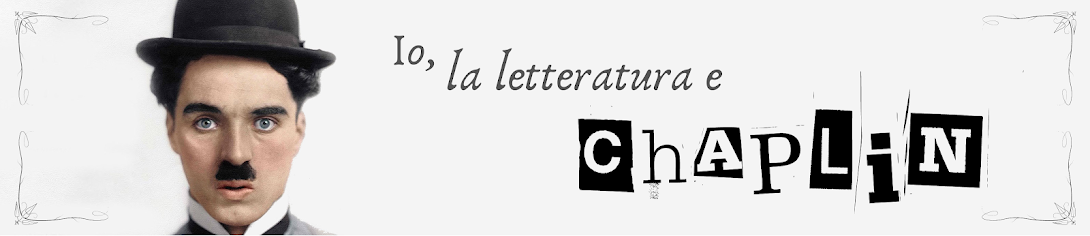


Nessun commento:
Posta un commento